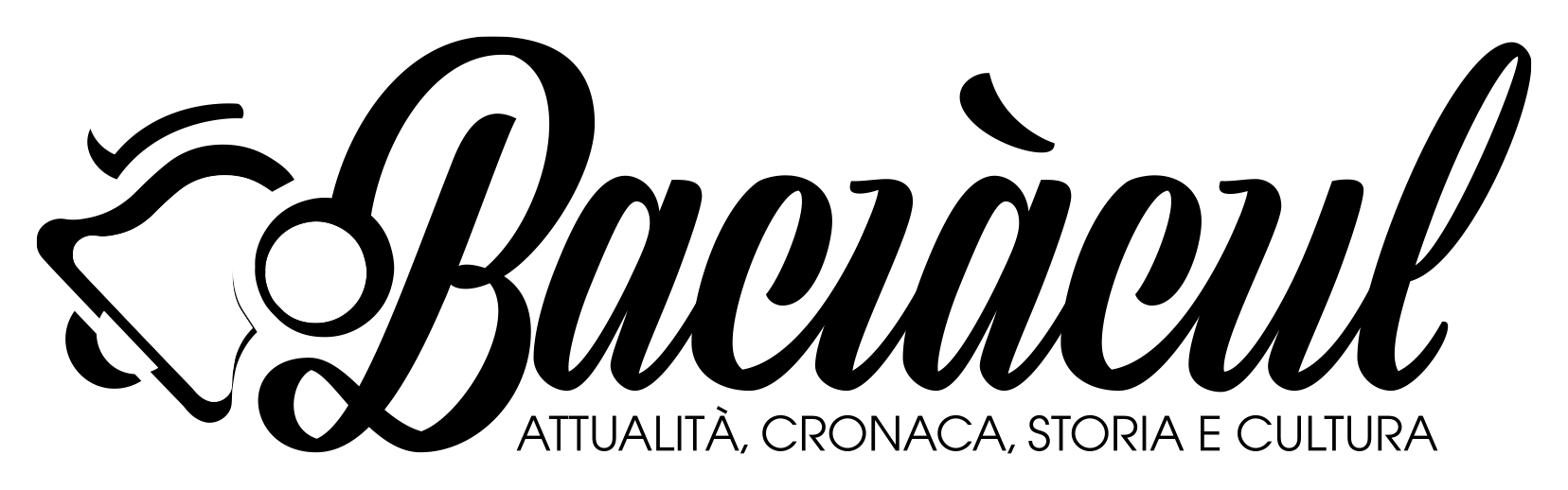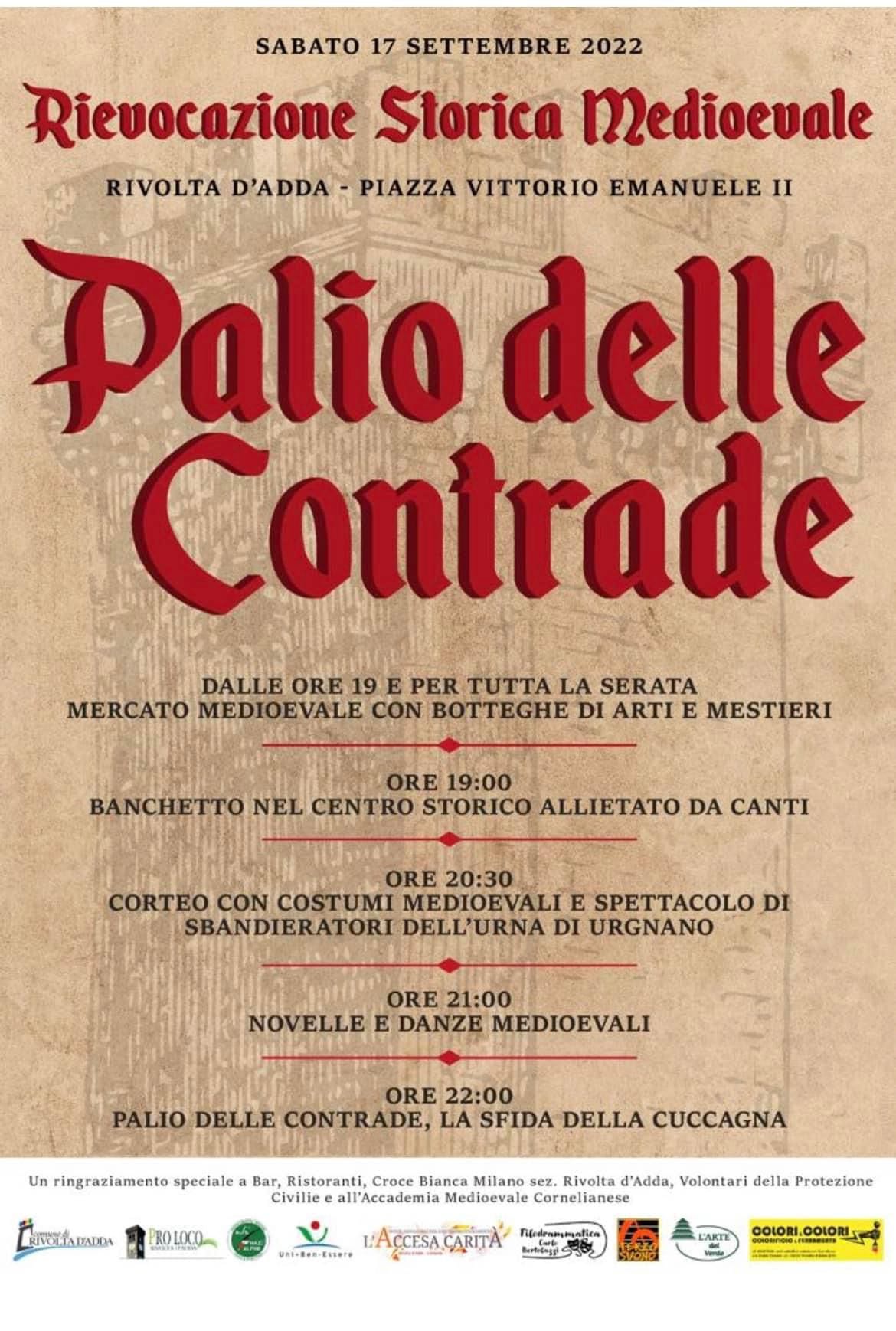Ripubblichiamo un interessante articolo scritto dall’indimenticabile Prof. Eugenio Calvi che descrive la chiesa consegnataci dalla tradizione quale edificio sorto su quella che fu la casa natale del nostro Santo Patrono. Questo testo è stato pubblicato su “La Voce di Sant’Alberto” nel Giugno 1995
La facciata – niente da dire – è ariosa, incantevole. E se si pensa che la chiesa di S. Alberto è del 1731, vien fatto di credere che il progettista fosse già presago dell’imminente brusca virata delle istanze artistiche in genere (e in particolare di quelle architettoniche) verso un ricupero dell’equilibrio e della compostezza della lezione classica, dopo l’ubriacatura del Barocco e le estenuate eleganze del Rococò.
 Se per un momento infatti non badiamo a quella cornicetta che contiene la ben nota dicitura (messa lì per informarci come in luogo del tempio una volta ci fosse la casa del Santo; un latino molto trasparente, in verità, ma che ha sempre frustrato le mire esibizionistiche dei traduttori in erba per via di un est e di un fuit impietosamente sottintesi e tali da rendere oscura, ermetica, quasi indecifrabile la frase), la facciata è liscia, solo mossa ai lati da quelle due brevi rientranze che sembrano più voler predisporre alla base la sede per le strutture del pozzo e della teca dei Morti che non per ricordare che in fin dei conti siamo soltanto ai primi del Settecento.
Se per un momento infatti non badiamo a quella cornicetta che contiene la ben nota dicitura (messa lì per informarci come in luogo del tempio una volta ci fosse la casa del Santo; un latino molto trasparente, in verità, ma che ha sempre frustrato le mire esibizionistiche dei traduttori in erba per via di un est e di un fuit impietosamente sottintesi e tali da rendere oscura, ermetica, quasi indecifrabile la frase), la facciata è liscia, solo mossa ai lati da quelle due brevi rientranze che sembrano più voler predisporre alla base la sede per le strutture del pozzo e della teca dei Morti che non per ricordare che in fin dei conti siamo soltanto ai primi del Settecento.
Ma quello che fa stare davvero col naso in su per un bel po’ è il cornicione. Le sue volute leggiadre (non trovo un aggettivo migliore tra quelli in uso nei tempi nostri) – che alla musicalità dei ritmi uniscono l’assoluta padronanza della materia bruta, piegata quasi con nonchalance in angolazioni impensate e in curve arditissime – ornano il fastigio del tempio e hanno il sapore come di un congedo, rivolto al vecchio Seicento, da un secolo nuovo che ormai si fa avanti con dottrine e voci fresche. Ma quei dentelli leggeri che definiscono e moderano la libera lievità delle curve segnate dal cornicione, e che sono costituiti dall’affiorare: delle tegole sul bordo, dimostrano ancora una volta come il senso spontaneo e felice del vero artista sappia trarre una nota musicale e viva da qualunque spunto, anche quello offerto dal più umile dei materiali, senza “ché ci sia bisogno sempre di ricorrere all’aristocratica nobiltà del marmo.
Entriamo…
Entriamo in chiesa, dopo aver dato una fuggevole occhiata al legno del portone e alla parte bassa della béola del portale che le intemperie e i rovesci di pioggia vanno sempre più corrodendo (no, signora Pasquini, lei che mi va facendo strada con la cortesia che distingue chi è di origine piemontese, no! me lo lasci dire subito: i Rivoltani non eran generosi solo quando eran poveri e sapevano costruire cose che ancor oggi fanno invidia a quelli che abitano nelle grandi città. Generosi lo sono ancora, e forse più di prima: basta solo che trovino chi li sappia con intelligenza chiamare a far onore al loro nome, e allora lasciano indietro anche i Milanesi, perché i Rivoltani son capaci di passar davanti anche a quelli cunt el coer in màn!).
Sì, guardiamo un po’ tutto. Ammiriamo le pitture, gli affreschi (quelli ancora non rovinati dall’umidità e dagli anni: non molti purtroppo); i vari modesti “tesori” della chiesa (tenuti peraltro con meticolosa cura); guardiamo gli armadi della sagrestia, le due enormi tele sei/settecentesche lì appoggiate al muro a marcire, in attesa di un restauro urgente che le sottragga a una rovina irreparabile (come sta avvenendo per tante altre cose, qui da noi).
Torniamo, piuttosto rattristati, verso l’uscita. Ci ha raggiunto, camminando faticosamente, anche il marito della Signora, fedele custode della chiesa da quando si può dire era un ragazzo. Ora anche lui è oppresso dagli acciacchi senili (la signora non perde l’occasione di lusingarmi, tessendomi le lodi di mio figlio, il loro medico di famiglia): ma negli occhi di quell’uomo… nei suoi occhi c’è ancora l’antico ardire di chi seppe sempre difendere quelle sacre mura e quelle venerande memorie da tutto e da tutti, senza mai ricavarne altro se non l’onore di continuare una centenaria tradizione familiare.
Mi fermo a guardare la statua di Sant’Antonio da Padova (non lontano, ma più piccola, c’è quella di Sant’Antonio Abate, col suo bravo porcello ai piedi). Forse loro ne intuiscono il perché: la Signora infatti mi dice che in tempi lontani quella statua era stata ripescata non senza pericolo nelle acque dell’Adda.
Vede che lo so, perché le dico anche l’anno: 1747. Ma non può del tutto rendersi conto del perché io mi trattenga così a lungo davanti a quella statua che – in verità – col “Cristo flagellato” posto sull’altare che le sta dirimpetto (sa che quel ragazzo, il Cagna, lo vuol restaurare, appena si è laureato? che bravo!) per valore artistico non può certo competere. Già, ma quella statua di Sant’Antonio ha una storia non comune. Era stata posta nell’Oratorio del Lazzaretto, costruito nel 1663 (e sono ormai 332 anni, per intenderci) in fondo a quello che è oggi il Viale delle Rimembranze, ma molto più a sud della chiesetta attuale (eretta, come qualcuno ricorderà ancora, una settantina di anni fa). Le acque dell’Adda, nella disastrosa piena del 1747, portarono via il piccolo edificio sacro e il terreno in cui erano sepolte le trecento e passa vittime della Peste Universale, durata – qui da noi – dal 1629 al 1630.
Scrisse un cronista del tempo: “[fu doloroso] vedersi spiantare fino da fondamenti l’oratorio detto del Lazzeretto, ove si venerava la divota statua di S. Antonio da Padova e fu sì improvviso l’incidente che non fu permesso di trasportare il più considerabile. Allorché fu veduta la detta Statua del Santo fra l’onde, alcuni animosi divoti si posero all’acqua e gli riuscì di ricuperarla, e fu riposta in questa nuova chiesa di Sant’Alberto.”
Così, quella statua non solo rappresenta e ricorda la religiosità e le benemerenze dei Rivoltani, ma è strettamente legata anche alla storia del nostro paese, il borgo gentile sfiorato dalle acque dell’Adda, lambìto dal bel fiume che ci è amico, ma che non tollera facilmente d’esser piegato ai voleri degli uomini, perché – se e quando vuole – può ricordare ai saccenti di ogni tempo che una forza della Natura non sarà mai domata del tutto da nessuno.
Saluto i miei buoni amici. Oltre a tutte le altre cose, ci unisce il senso d’impotenza di fronte al vacillare di tante care speranze: tornerà la devozione al nostro grande Santo? Riprenderà senso, nel tempo, quella “rivoltanità” che ci permetteva di sentirci diversi e non “integrati” come gli anonimi abitanti dei quartieri suburbani della metropoli?
I Rivoltani hanno sempre avuto l’orgoglio di essere quello che sono. Il ponte che li ha uniti al Milanese, terra di lavoro e di sicuri guadagni, non è mai stato realizzato se non nella seconda metà dell’Ottocento, e l’Adda – con incredibile spietata intuizione – lo ha lasciato in piedi solo un anno e poi lo ha travolto con le sue acque irate e limacciose, quasi a voler ammonire di guardarci dal cadere nell’appiattimento dello spirito che è il primo frutto amaro del vivere lontani dalla propria terra e che è sempre attossicato di volgarità e di frode.
Il campaniletto della Chiesa di S. Alberto, con la sua forma triangolare ardita e ribelle (mi dicono che in Italia ce n’è forse uno, uno solo uguale; gli altri due o tre bisogna cercarli qua e lì nell’immensità dell’Europa) ci è di monito: noi dobbiamo raccoglierci sotto l’ala protettrice del nostro Santo per difenderci da quella nuova barbarie che non è più quella dei “tedeschi lurchi” di Federico Barbarossa, ma l’ultima, la più recente e insidiosa, quella che rappresenta la più umiliante delle nefandezze: la clonazione dell’intelletto e dello spirito.
Eugenio Calvi
Fotografie fornite dal Gruppo Fotografico Rivoltano
Rivolta da scoprire
Scopri le bellezze rivoltane, segui i percorsi per trovarle e fatti guidare per una loro visita, su:
https://www.prolocorivolta.com